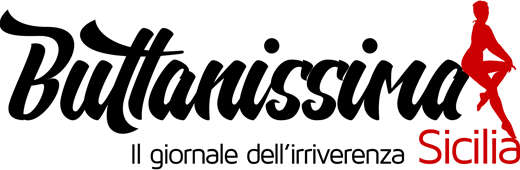Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, avrebbe dovuto rappresentare una svolta, un’occasione per uscire dall’isolamento e restituire centralità alla visione, alla progettualità, alla bellezza di un luogo senza pari. E invece si ritrova oggi invischiata in tensioni istituzionali, ritardi, comunicazioni opache e dimissioni che pesano come macigni.
Quelle di Roberto Albergoni, direttore generale del progetto, hanno fatto rumore. Uomo di cultura, con esperienza e credibilità, ha lasciato un incarico cruciale, reso insostenibile non da motivi personali, ma da un clima che ne ha svuotato la funzione. Le parole riportate dalle agenzie, con cui la presidente della Fondazione – già prefetta, quindi figura del potere amministrativo, non della cultura – avrebbe commentato l’addio, lasciano interdetti: “Ha tolto dall’imbarazzo il consiglio di amministrazione, evitandogli un atto più doloroso”. Come se la cultura fosse un peso da scaricare. Come se il problema fosse la presenza di chi porta idee, e non la mancanza di strumenti per sostenerle.
Ma l’imbarazzo non è una categoria della responsabilità. È un riflesso di chi è privo di visione e teme il confronto. È il sintomo di un potere che non sa reggere il volto libero della cultura, e allora preferisce sopprimerla. In questo gesto c’è qualcosa di grave, di irreparabile: la cultura non viene soltanto ostacolata, ma sistematicamente resa impossibile dalla politica.
Chi porta visione, chi prova a innovare, viene accompagnato all’uscita. Non c’è spazio per il conflitto costruttivo, per la pluralità, per lo slancio. Non c’è spazio per l’oltre. Il potere – e nello specifico quello politico – più che promuovere la cultura, sembra preferire la sclerotizzazione, l’immobilità. Il cambiamento è ammesso solo se non disturba. Si scoraggia la creatività, si isola chi osa, si espunge chi ha uno sguardo diverso, come una spina da un dito. E così Agrigento rischia di restare ferma, come congelata. Una città che ha paura di osare, costretta al silenzio e all’obbedienza. Di lei resta il nome, non la voce.
Impossibile, a questo punto, non evocare Le mosche di Jean-Paul Sartre. Una tragedia scritta nel 1943, in piena occupazione nazista, ambientata in una città dominata dal rimorso e dal culto della penitenza. Le mosche, simbolo di colpa e rassegnazione, infestano ogni spazio. Solo Oreste – eroe tragico e libero – ha il coraggio di spezzare il circolo della paura. “La libertà – scriveva Sartre – non è il potere astratto di sorvolare la condizione umana: è il più assurdo e inesorabile degli impegni. Oreste andrà avanti per la sua strada, senza giustificazioni, senza scuse, senza ritorni. Solo. Come un eroe, come non importa chi”.
Agrigento somiglia oggi a quella Argo: una città dove il palco è pronto, ma il sipario non si alza. Dove le locandine scoloriscono prima ancora di essere lette, e le idee si smontano prima di prendere forma. Dove le mosche – inesorabili e ostinate – si nutrono dei resti di progetti abbandonati e ronzano attorno al cadavere della cultura civile.
E mentre Albergoni si volge al suo altro impegno nel progetto “Gibellina Capitale Italiana dell’Arte 2026”, promosso anche dalla Fondazione Orestiadi, la figura di Oreste torna alla ribalta: da una parte respinto da una città che nega la cultura, dall’altra accolto – è curioso notarlo – proprio in un luogo che porta il suo nome. Oreste ritorna a Gibellina, città ferita eppure risorta attraverso l’arte. Agrigento, invece, lo ha lasciato andare via.
La domanda ora è: chi avrà il coraggio di salire su quel palco vuoto, sfidare il ronzio e parlare a voce alta? Chi restituirà la piazza ai vivi, invece che lasciarla alla macabra suggestione dei resti?
Eppure, anche tra chi ha provato a costruire visione, qualche responsabilità resta. Forse Albergoni avrebbe potuto resistere, rivendicare con più forza il proprio ruolo, non cedere la scena così facilmente. Forse avrebbe potuto restare, pur sapendo di essere scomodo. Ma anche questo fa parte del tragico: la solitudine di chi ha idee in un contesto che non le vuole. E il rischio che il gesto della rinuncia venga scambiato per sollievo da parte di chi resta.
Le mosche continueranno a danzare finché nessuno proverà davvero a scacciarle. Finché la politica non saprà riconoscere la cultura, le mosche continueranno a banchettare. Perché ciò che non si conosce, si teme. E ciò che si teme, si elimina.