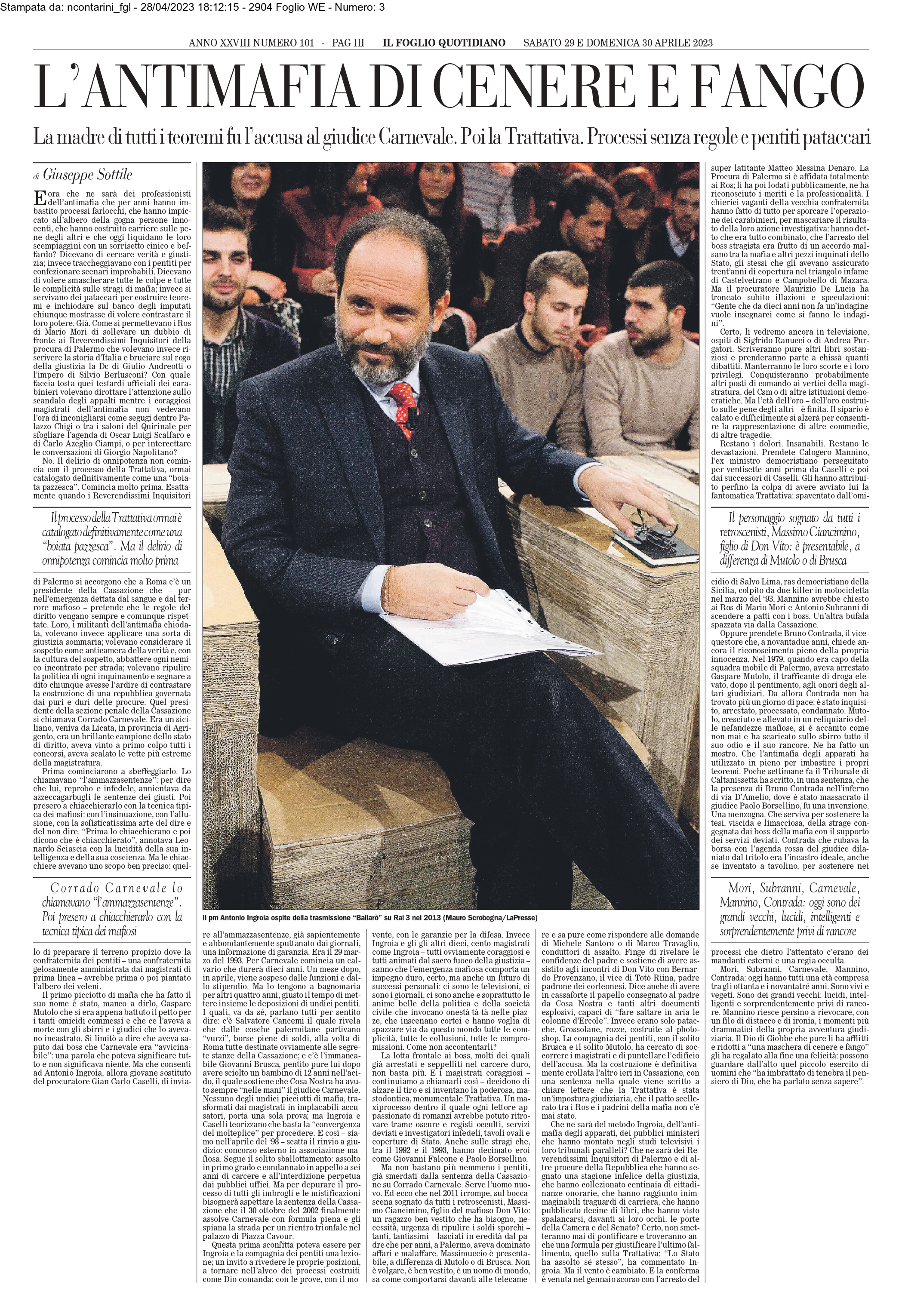E ora che ne sarà dei professionisti dell’antimafia che per anni hanno imbastito processi farlocchi, che hanno impiccato all’albero della gogna persone innocenti, che hanno costruito carriere sulle pene degli altri e che oggi liquidano le loro scempiaggini con un sorrisetto cinico e beffardo? Dicevano di cercare verità e giustizia; invece traccheggiavano con i pentiti per confezionare scenari improbabili. Dicevano di volere smascherare tutte le colpe e tutte le complicità sulle stragi di mafia; invece si servivano dei pataccari per costruire teoremi e inchiodare sul banco degli imputati chiunque mostrasse di volere contrastare il loro potere. Già. Come si permettevano i Ros di Mario Mori di sollevare un dubbio di fronte ai Reverendissimi Inquisitori della procura di Palermo che volevano invece riscrivere la storia d’Italia e bruciare sul rogo della giustizia la Dc di Giulio Andreotti o l’impero di Silvio Berlusconi? Con quale faccia tosta quei testardi ufficiali dei carabinieri volevano dirottare l’attenzione sullo scandalo degli appalti mentre i coraggiosi magistrati dell’antimafia non vedevano l’ora di inconigliarsi come segugi dentro Palazzo Chigi o tra i saloni del Quirinale per sfogliare l’agenda di Oscar Luigi Scalfaro e di Carlo Azelio Ciampi, o per intercettare le conversazioni di Giorgio Napolitano?
No. Il delirio di onnipotenza non comincia con il processo della Trattativa, ormai catalogato definitivamente come una “boiata pazzesca”. Comincia molto prima. Esattamente quando i Reverendissimi Inquisitori di Palermo si accorgono che a Roma c’è un presidente della Cassazione che – pur nell’emergenza dettata dal sangue e dal terrore mafioso – pretende che le regole del diritto vengano sempre e comunque rispettate. Loro, i militanti dell’antimafia chiodata, volevano invece applicare una sorta di giustizia sommaria; volevano considerare il sospetto come anticamera della verità e, con la cultura del sospetto, abbattere ogni nemico incontrato per strada; volevano ripulire la politica di ogni inquinamento e segnare a dito chiunque avesse l’ardire di contrastare la costruzione di una repubblica governata dai puri e duri delle procure. Quel presidente della sezione penale della Cassazione si chiamava Corrado Carnevale. Era un siciliano, veniva da Licata, in provincia di Agrigento, era un brillante campione dello stato di diritto, aveva vinto a primo colpo tutti i concorsi, aveva scalato le vette più estreme della magistratura.
Prima cominciarono a sbeffeggiarlo. Lo chiamavano “l’ammazasentenze”: per dire che lui, reprobo e infedele, annientava da azzeccagarbugli le sentenze dei giusti. Poi presero a chiacchierarlo con la tecnica tipica dei mafiosi: con l’insinuazione, con l’allusione, con la sofisticatissima arte del dire e del non dire. “Prima lo chiacchierano e poi dicono che è chiacchierato”, annotava Leonardo Sciascia con la lucidità della sua intelligenza e della sua coscienza. Ma le chiacchiere avevano uno scopo ben preciso: quello di preparare il terreno propizio dove la confraternita dei pentiti – una confraternita gelosamente amministrata dai magistrati di prima linea – avrebbe prima o poi piantato l’albero dei veleni.
Il primo picciotto di mafia che ha fatto il suo nome è stato, manco a dirlo, Gaspare Mutolo che si era appena battuto il petto per i tanti omicidi commessi e che ce l’aveva a morte con gli sbirri e i giudici che lo avevano incastrato. Si limitò a dire che aveva saputo dai boss che Carnevale era “avvicinabile”: una parola che poteva significare tutto e non significava niente. Ma che consentì ad Antonio Ingroia, allora giovane sostituto del procuratore Gian Carlo Caselli, di inviare all’ammazzasentenze, già sapientemente e abbondantemente sputtanato dai giornali, una informazione di garanzia. Era il 29 marzo del 1993. Per Carnevale comincia un calvario che durerà dieci anni. Un mese dopo, in aprile, viene sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. Ma lo tengono a bagnomaria per altri quattro anni, giusto il tempo di mettere insieme le deposizioni di undici pentiti. I quali, va da sé, parlano tutti per sentito dire: c’è Salvatore Cancemi il quale rivela che dalle cosche palermitane partivano “vurzi”, borse piene di soldi, alla volta di Roma tutte destinate ovviamente alle segrete stanze della Cassazione; e c’è l’immancabile Giovanni Brusca, pentito pure lui dopo avere sciolto un bambino di 12 anni nell’acido, il quale sostiene che Cosa Nostra ha avuto sempre “nelle mani” il giudice Carnevale. Nessuno degli undici picciotti di mafia, trasformati dai magistrati in implacabili accusatori, porta una sola prova; ma Ingroia e Caselli teorizzano che basta la “convergenza del molteplice” per procedere. E così – siamo nell’aprile del ’98 – scatta il rinvio a giudizio: concorso esterno in associazione mafiosa. Segue il solito sballottamento: assolto in primo grado e condannato in appello a sei anni di carcere e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ma per depurare il processo di tutti gli imbrogli e le mistificazioni bisognerà aspettare la sentenza della Cassazione che il 30 ottobre del 2002 finalmente assolve Carnevale con formula piena e gli spiana la strada per un rientro trionfale nel palazzo di Piazza Cavour.
Questa prima sconfitta poteva essere per Ingroia e la compagnia dei pentiti una lezione; un invito a rivedere le proprie posizioni, a tornare nell’alveo dei processi costruiti come Dio comanda: con le prove, con il movente, con le garanzie per la difesa. Invece Ingroia e gli gli altri dieci, cento magistrati come Ingroia – tutti ovviamente coraggiosi e tutti animati dal sacro fuoco della giustizia – sanno che l’emergenza mafiosa comporta un impegno duro, certo, ma anche un futuro di successi personali: ci sono le televisioni, ci sono i giornali, ci sono anche e soprattutto le anime belle della politica e della società civile che invocano onestà-tà-tà nelle piazze, che inscenano cortei e hanno voglia di spazzare via da questo mondo tutte le complicità, tutte le collusioni, tutte le compromissioni. Come non accontentarli?
La lotta frontale ai boss, molti dei quali già arrestati e seppelliti nel carcere duro, non basta più. E i magistrati coraggiosi – continuiamo a chiamarli così – decidono di alzare il tiro e si inventano la poderosa, mastodontica, monumentale Trattativa. Un maxiprocesso dentro il quale ogni lettore appassionato di romanzi avrebbe potuto ritrovare trame oscure e registi occulti, servizi deviati e investigatori infedeli, tavoli ovali e coperture di Stato. Anche sulle stragi che, tra il 1992 e il 1993, hanno decimato eroi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Ma non bastano più nemmeno i pentiti, già smerdati dalla sentenza della Cassazione su Corrado Carnevale. Serve l’uomo nuovo. Ed ecco che nel 2011 irrompe, sul boccascena sognato da tutti i retroscenisti, Massimo Ciancimino, figlio del mafioso Don Vito: un ragazzo ben vestito che ha bisogno, necessità urgenza di ripulire i soldi sporchi – tanti, tantissimi – lasciati in eredità dal padre che per anni, a Palermo, aveva dominato affari e malaffare. Massimuccio è presentabile, a differenza di Mutolo o di Brusca. Non è volgare, è ben vestito, è un uomo di mondo, sa come comportarsi davanti alle telecamere e sa pure come rispondere alle domande di Michele Santoro o di Marco Travaglio, conduttori di assalto. Finge di rivelare le confidenze del padre e sostiene di avere assistito agli incontri di Don Vito con Bernardo Provenzano, il vice di totò Riina, padre padrone dei corleonesi. Dice anche di avere in cassaforte il papello consegnato al padre da Cosa Nostra e tanti altri documenti esplosivi, capaci di “fare saltare in aria le colonne d’Ercole”. Invece erano solo patacche. Grossolane, rozze, costruite al fotoshop. La compagnia dei pentiti, con il solito Brusca e il solito Mutolo, ha cercato di soccorrere i magistrati e di puntellare l’edificio dell’accusa. Ma la costruzione è definitivamente crollata l’altro ieri in Cassazione, con una sentenza nella quale viene scritto a chiare lettere che Trattativa è stata un’impostura giudiziaria, che il patto scellerato tra i Ros e i padrini della mafia non c’è mai stato.
Che ne sarà del metodo Ingroia, dell’antimafia degli apparati, dei pubblici ministeri che hanno montato negli studi televisivi i loro tribunali paralleli? Che ne sarà dei Reverendissimi Inquisitori di Palermo e di altre procure della Repubblica che hanno segnato una stagione infelice della giustizia, che hanno collezionato centinaia di cittadinanze onorarie, che hanno raggiunto inimmaginabili traguardi di carriera, che hanno pubblicato decine di libri, che hanno visto spalancarsi, davanti ai loro occhi, le porte della Camera e del Senato? Certo, non smetteranno mai di pontificare e troveranno anche una formula per giustificare l’ultimo fallimento, quello sulla Trattativa: “Lo Stato ha assolto sé stesso”, ha commentato Ingroia. Ma il vento è cambiato. E la conferma è venuta nel gennaio scorso con l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. La Procura di Palermo si è affidata totalmente ai Ros; li ha poi lodati pubblicamente, ne ha riconosciuto i meriti e la professionalità. I chierici vaganti della vecchia confraternita hanno fatto di tutto per sporcare l’operazione dei carabinieri, per mascariare il risultato della loro azione investigativa: hanno detto che era tutto combinato, che l’arresto del boss stragista era frutto di un accordo malsano tra la mafia e altri pezzi inquinati dello Stato, gli stessi che gli avevano assicurato trent’anni di copertura nel triangolo infame di Castelvetrano e Campobello di Mazara. Ma il procuratore Maurizio De Lucia ha troncato subito illazioni e speculazioni: “Gente che da dieci anni non fa un’indagine vuole insegnarci come si fanno le indagini”.
Certo, li vedremo ancora in televisione, ospiti di Sigfrido Ranucci o di Andrea Purgatori. Scriveranno pure altri libri sostanziosi e prenderanno parte a chissà quanti dibattiti. Manterranno le loro scorte e i loro privilegi. Conquisteranno probabilmente altri posti di comando ai vertici della magistratura, del Csm o di altre istituzioni democratiche. Ma l’età dell’oro – dell’oro costruito sulle pene degli altri – è finita. Il sipario è calato e difficilmente si alzerà per consentire la rappresentazione di altre commedie, di altre tragedie.
Restano i dolori. Insanabili. Restano le devastazioni. Prendete Calogero Mannino, l’ex ministro democristiano perseguitato per ventisette anni prima da Caselli e poi dai successori di Caselli. Gli hanno attribuito perfino la colpa di avere avviato lui la fantomatica Trattativa: spaventato dall’omicidio di Salvo Lima, ras democristiano della Sicilia, colpito da due killer in motocicletta nel marzo del ’92, Mannino avrebbe chiesto ai Ros di Mario Mori e Antonio Subranni di scendere a patti con i boss. Un’altra bufala spazzata via dalla Cassazione.
Oppure prendete Bruno Contrada, il vicequestore che, a novanta due anni, chiede ancora il riconoscimento pieno della propria innocenza. Nel 1979, quando era capo della squadra mobile di Palermo, aveva arrestato Gaspare Mutolo il trafficante di droga elevato, dopo il pentimento, agli onori degli altari giudiziari. Da allora Contrada non ha trovato più un giorno di pace: è stato inquisito, arrestato, processato, condannato. Mutolo, cresciuto e allevato in un reliquiario delle nefandezze mafiose, si è accanito come non mai e ha scaricato sullo sbirro tutto il suo odio e il suo rancore. Ne ha fatto un mostro. Che l’antimafia degli apparati ha utilizzato in pieno per imbastire i propri teoremi. Poche settimane fa il Tribunale di Caltanissetta ha scritto, in una sentenza, che la presenza di Bruno Contrada nell’inferno di via D’Amelio, dove è stato massacrato il giudice Paolo Borsellino, fu una invenzione. Una menzogna. Che serviva per sostenere la tesi, viscida e limacciosa, della strage congegnata dai boss della mafia con il supporto dei servizi deviati. Contrada che rubava la borsa con l’agenda rossa del giudice dilaniato dal tritolo era l’incastro ideale, anche se inventato a tavolino, per sostenere nei processi che dietro l’attentato c’erano dei mandanti esterni e una regia occulta.
Mori, Subranni, Carnevale, Mannino, Contrada: oggi hanno tutti una età compresa tra gli ottanta e i novantatré anni. Sono vivi e vegeti. Sono dei grandi vecchi: lucidi, intelligenti e sorprendentemente privi di rancore. Mannino riesce persino a rievocare, con un filo di distacco e di ironia, i momenti più drammatici della propria avventura giudiziaria. Il Dio di Giobbe che pure li ha afflitti e ridotti a “una maschera di cenere e fango” gli ha regalato alla fine una felicità: possono guardare dall’alto quel piccolo esercito di uomini che “ha imbrattato di tenebra il pensiero di Dio, che ha parlato senza sapere”.