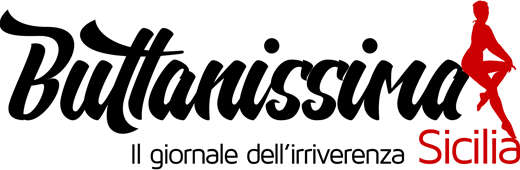In forma smagliante come chi ostenta un importante successo, a Milano, pochi giorni fa, Meloni ha annesso la CISL, accostando una delle maggiori organizzazioni sindacali, componente di quella che un tempo veniva chiamata la Triplice, alla «Fiamma», al simbolo del suo partito, a quel fuoco al quale la presidente del Consiglio non intende rinunciare.
Quel successo mostrato con orgoglio viola una storia lunga, capovolge una grande tradizione, eppure è stato applaudito dai delegati al congresso nazionale in modo così ripetuto e intenso da non esprimere solo la doverosa cortesia nei confronti di un’ospite illustre, ma da manifestare una entusiastica adesione.
Il fragore degli applausi era tale da provocare, mi viene da dire, il distacco dalle pareti del palazzo di via Po a Roma, sede storica del sindacato, delle fotografie di Giulio Pastore, di Bruno Storti, di Pierre Carniti e di Franco Marini, per citare alcuni degli esponenti che si sono succeduti nel tempo alla guida dell’organizzazione.
Se ne andavano, quei ritratti, per evitare di venire imbrattati, per non assistere allo sfregio della loro storia, per non continuare ad essere i numi, non si sa quanto conosciuti del resto da quelli che a loro ancora dovrebbero richiamarsi, di un sindacato che si è meritato il ruolo di interlocutore affidabile della premier.
Non hanno accettato, quei protagonisti della storia sindacale e nazionale, di essere considerati scorie di un passato ideologico novecentesco, non volevano vedere stravolta la loro memoria, la memoria di chi aveva dato voce ai lavoratori italiani e aveva bloccato nella Democrazia cristiana nella quale militavano ogni tentazione di abbattere le barriere a destra.
A Milano la premier ha fatto bene, come al solito, il suo lavoro: dividere i buoni, disposti ad interloquire «senza pregiudizio», a collaborare con il suo governo, da chi mantiene una «tossica visione conflittuale». E i buoni hanno apprezzato con ripetute battute di mano anche l’elenco delle mirabilie snocciolate da Meloni e hanno mostrato di essere pienamente a loro agio in una struttura rinnovata che si colora di «giallo», come quei sindacati creati dai datori di lavoro o dai governi e che la nostra Costituzione vieta.
La storia a volte attorta, si imparpuglia, svolta ad U, utilizza uomini e donne senza memoria né radici né dignità.
Mentre ascoltavo la presidente del consiglio, pensavo al difficile processo dell’unità sindacale, a cominciare dalla scelta di Luciano Lama di abbandonare la Federazione Sindacale Mondiale che aveva la propria sede a Mosca. Da allora, a metà degli anni Sessanta, si compose gradualmente la rottura avvenuta al tempo del Partito comunista italiano stalinista, quando la CGIL era individuata come «la sua cinghia di trasmissione».
Superate le contrapposizioni, l’unità diede ai lavoratori la forza per ottenere migliori condizioni di vita, per avere riconosciuti i propri diritti, per conquistare una propria dignità, per contribuire alla nascita del welfare che da decenni segna la vita della nostra comunità.
Mi è tornato in mente anche il personale debito di riconoscenza nei confronti della CISL siciliana.
In tempi lontani, accanto a Vito Scalia, parlamentare democristiano catanese e segretario generale aggiunto di quel sindacato, partecipai alla nascita, all’interno della Democrazia cristiana, del gruppo di «Nuova sinistra», divenendone responsabile nell’Isola.
Aprii allora una sede per ospitare le segreterie dei quattro deputati regionali che la corrente riuscì a fare eleggere nel 1971. L’anno appresso il sostegno di alcuni di loro risultò determinante per la mia prima elezione, difficile a motivo della giovane età, a causa della mancanza di potere ma anche per quella locuzione, «Nuova sinistra», che mi accompagnava e mi veniva spesso contestata.
Poco dopo ho contribuito all’affermazione di un gruppo dirigente sindacale di grande valore, che gestì prima la CISL regionale per arrivare poi, con Sergio Dantoni e Luigi Cocilovo, alla guida di quella nazionale.
Da allora non ho mai smesso, anche dopo la conclusione della mia esperienza parlamentare, di seguire le sue vicende.
Anche al tempo al quale mi riferisco i rappresentanti delle tre organizzazioni avevano una collocazione politica, militavano all’interno di un partito, a volte ne erano parte attiva e determinante, alcuni erano presenti in Parlamento, fino a quando non venne stabilita l’incompatibilità tra incarichi politici e sindacali.
Tuttavia l’unità, la necessità di confrontarsi, di concordare le scelte e le modalità delle lotte rendevano quasi sempre autonomo il sindacato, ne facevano una delle grandi espressioni della democrazia, della partecipazione e un protagonista della storia del Paese.
Dovevano, ed era il loro compito, rappresentare gli interessi degli associati e non quello dei partiti.
Oggi è tutto diverso ed è giusto cogliere le diversità, abbandonare il residuo di ideologismo novecentesco. Mi pare comunque errato operare privi di alcun punto di riferimento politico e culturale, superare le barriere che dovrebbero continuare ad essere visibili e rispettate, capovolgere storie e tradizioni.
L’intervento di Meloni al congresso di Milano ha ratificato un processo avviato da qualche tempo, ha allargato il fossato tra le tre organizzazioni sindacali, ha indebolito il mondo del lavoro, ha ridotto una parte di esse ad appendice di una forza politica, a cinghia di trasmissione, come giusto si diceva.
Due riflessioni finali. La presidente del consiglio nel capoluogo lombardo ha proseguito lungo una linea dalla quale non si distacca: rappresentare una parte dell’elettorato, contrapporre amici e nemici, dividere il Paese, colpire le strutture intermedie di rappresentanza. Ha fatto ciò che fa la destra non solo in Italia. Definisce tossico il conflitto che, al di là del riferimento al veleno, ha quasi cessato di esistere. La battaglia, la lotta di classe, come dicevano i marxisti, è stata vinta, sembra definitivamente, dai ricchi, che stanno conquistando senza intralci il governo del mondo, col consenso e talora perfino il plauso dei poveri, abbandonati nella loro solitudine, impauriti, imboniti dai mezzi di comunicazione.
Seconda riflessione. Da Milano viene un’ulteriore dimostrazione della incapacità della sinistra di rappresentare il mondo del lavoro e tanti lavoratori scelgono la destra, mentre altri non votano per nulla.