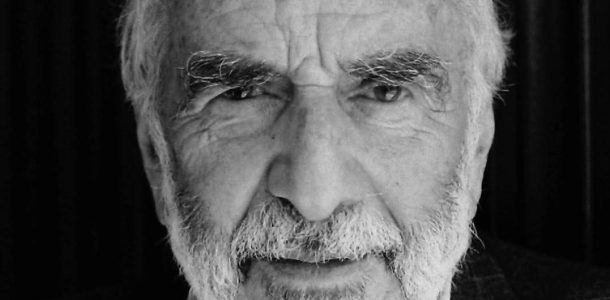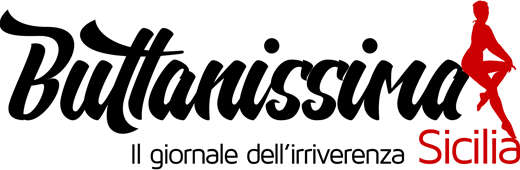Pochi giorni fa, in modo provocatorio ho chiesto di spegnere i motori di Agrigento Capitale della cultura, una macchina che del resto finora ha girato su se stessa. Torno a scrivere sullo stesso argomento. Non per una fissazione, per un pregiudizio, per un fatto personale, ma perché questa vicenda è diventata una metafora che trasmette e diffonde un racconto negativo della città e della Sicilia. Torno a scriverne perché condivido – e cerco di farmene portavoce – una indignazione diffusa anche se in parte repressa da una inveterata predisposizione alla rassegnazione e da un controllo capillare e forte ad opera di un potere locale che mette in atto tutti i mezzi per bloccare il dissenso.
Torno a scriverne perché, malgrado ogni evidenza, spero ancora, per quanto il tempo che rimane rende possibile, che questa vicenda cambi direzione.
La speranza è l’ultima a morire ma in questo caso è molto vicina all’estinzione.
La provocazione del precedente articolo ha suscitato la stizzita reazione del sindaco, che alterna spensierata levità quando assicura che tutto va bene ad intolleranza per ogni critica alla quale, a motivo dell’attività che svolge, dovrebbe essere aduso.
Una replica indispettita è venuta anche dalla presidente della Fondazione, abituata, lei, a svolgere le proprie funzioni dentro rigide regole gerarchiche che danno poco spazio al dissenso. Non è mia intenzione sollecitare la loro sensibilità.
Voglio ribadire però le domande senza risposta dell’Osservatorio permanente, di molte associazioni e dei cittadini, denunciare ancora l’indisponibilità al dialogo e all’ascolto, respingere l’accusa di fare opera di sabotaggio di chi tenta viceversa di trovare un modo per collaborare.
La porta della Fondazione rimane chiusa a doppia mandata e non c’è nessuna possibilità che vengano sostenute le iniziative delle associazioni e degli artisti del territorio, malgrado il finanziamento sia già stato previsto.
Non si consente alcuna forma di partecipazione, non si intende costruire un sistema di relazioni che creerebbe cittadinanza, solidarietà, favorirebbe la crescita civile, consentirebbe di dar valore ad energie e potenzialità inespresse, farebbe nascere l’orgoglio di divenire protagonisti di un grande evento, sentirlo proprio, percepire la cultura come concreto volano di sviluppo.
Agli agrigentini non può essere riservato il ruolo di spettatori dei prossimi eventi, non possono essere la clac per gli artisti che verranno nei prossimi mesi.
E di mesi non ne restano molti. Un quarto dell’anno è trascorso. Alcuni degli eventi previsti sono stati cancellati o rinviati e quelli realizzati o sicuramente da realizzare – la sagra del mandorlo, il carnevale di Sciacca e la festa di San Calogero – da decenni sono nella tradizione locale e nessuno di essi è in capo alla Fondazione. Ad una Fondazione di partecipazione che, contraddicendo in termini il significato letterale e giuridico, resta chiusa a chi volesse farne parte in proprio o in rappresentanza di realtà e di associazioni del territorio, a chi volesse fare da raccordo tra la struttura da una parte e la città e la provincia dall’altra. Si opera in solitudine. Non si fa nulla per attingere a capitali privati, per tentare di coinvolgere le banche che, per statuto, hanno l’obbligo di destinare parte dei ricavi a progetti di attività pubbliche.
A Brescia e a Bergamo, recenti Capitali della cultura, la Cariplo ha dato un contributo superiore a tre milioni di euro. Altre realtà e altri interessi. Qui non ci si prova neppure.
E del resto quale privato, quale istituto di credito vorrà essere coinvolto in questa Fondazione, che rimane priva di capitale e di patrimonio proprio da impiegare negli anni a venire?
Lo statuto dà ad essa un arco temporale di attività che arriva al 2028 e già dal 2023, se non dal 2015, quando è stato fatto il primo tentativo di ottenere la nomina, si sarebbe dovuto individuare un percorso, costruire un progetto per confermare e migliorare la vocazione turistica di Agrigento, renderla attrattiva per iniziative nuove nei settori più avanzati e moderni, farne una città permanente dell’arte e della cultura.
Una gestione amministrativa avveduta e un governo della Fondazione adeguato avrebbero potuto consolidare e rendere stabile il percorso difficile che la città ha iniziato da qualche anno per affermare, tra mille problemi e mille pesi del passato, un racconto di sé e un’immagine nuovi.
Si sarebbe potuto richiamare su Agrigento e sul suo territorio un’attenzione che, da Palermo, arrivasse a Roma e a Bruxelles, per eliminare o quanto meno attenuare il suo isolamento.
Ciò che si è fatto e ancor più quello che non si è fatto rischiano di riconsegnare all’opinione pubblica nazionale la città di un tempo, quella che si racconta nei suoi aspetti più contraddittori e negativi.
Si può ancora evitare il fallimento. Esiste la possibilità di recuperare almeno in parte il significato e il valore di Capitale della cultura, di tenere in vita le speranze nate dalla scelta del governo tra i cittadini, gli operatori del turismo, del commercio e tra gli artisti. Si possono utilizzare i mesi che restano alla fine dell’anno per dar vita agli eventi più significativi, a quelli che possono essere duraturi. Si può eliminare il pregiudizio nei confronti dei progetti delle associazioni del territorio per creare un legame sentimentale con la gente, coinvolgerla, consentirle di dialogare e non chiedere una sorta di silenzioso assenso. Si può trovare il modo di sottrarre l’amministrazione pubblica, almeno per ciò che riguarda Capitale della cultura, alla esclusiva disponibilità della maggioranza che la governa per aprire una pagina nuova con tutte le forze. Si può provare ad indurre i governi a spezzare l’isolamento. È possibile intervenire sull’arredo pubblico facendo di ogni strada e di ogni piazza il luogo d’incontro tra i cittadini e tra loro e i visitatori.
Si può fare tutto ciò. O per lo meno si può tentare. Occorre cominciare ora, avendo tre anni davanti.
Non si può recuperare il tempo perduto. Non si dovrebbe perdere quello che resta.