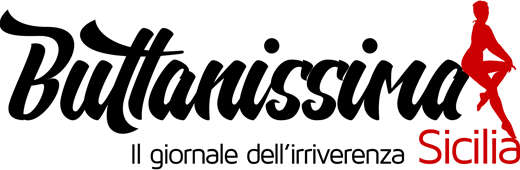Oggi Giorgia Meloni incontra il presidente degli Stati Uniti d’America per indurlo a rivedere la sua posizione sui dazi e più in generale sul rapporto con l’Europa e con l’Italia.
Non ha molte possibilità di successo, il nostro presidente del Consiglio, con un uomo sbilenco, instabile e pericoloso, per il quale amicizia e affinità ideologica non hanno valore alcuno.
Del resto, è questo il senso del sovranismo, che ciascuno pensa per sé, ignorando che la solidarietà rende forti, l’egoismo indebolisce e genera conflitti. Speriamo bene.
Tutti i nostri capi di governo dal dopoguerra hanno incontrato il presidente del Paese leader del mondo occidentale. Tutti hanno dovuto fare i conti con il suo ruolo e la sua forza. Tutti sono andati, come si è detto in questi giorni, a “baciare la pantofola” e solo quella, naturalmente. Il primo, nel gennaio del 1947, è stato Alcide De Gasperi.
Il ricordo di quell’evento non può indurre forzati confronti tra situazioni lontanissime e abissalmente diverse. Potrebbe magari essere utile a Meloni ricordare la postura, la dignità, la forza, il comportamento dell’uomo che allora rappresentava l’Italia, ancora due anni prima in guerra alleata della Germania nazista e del Giappone contro gli Stati Uniti d’America. Non era stato neppure firmato il trattato di pace a motivo dell’ostilità della Francia e della Gran Bretagna che continuavano a ritenerci nemici. Il Paese, governato dai partiti del Comitato di liberazione nazionale, era in macerie, con le case, le industrie, i sistemi di trasporto, i porti distrutti dai bombardamenti. Tutte le vie di comunicazione risultavano interrotte e mancava il lavoro. Gran parte dei nostri concittadini era alla fame. La tessera annonaria assegnava 200 grammi di pane al giorno a ciascuno, una quantità del tutto insufficiente ad assicurare la sopravvivenza. Pio XII dirà “I pargoli domandavano pane e non c’era chi lo desse”. Rimaneva grano per sole tre settimane. La povera gente era alla disperazione e il governo non sapeva che fare per evitare rivolte incontenibili e la rottura di ciò che restava della coesione sociale dopo la guerra e i suoi tragici esiti. Il clima politico tendeva a surriscaldarsi e i contrasti tra i partiti erano sempre più evidenti. Iniziava la guerra fredda e i comunisti, allineati alle posizioni di Mosca, manifestavano ostilità a quel viaggio, temendo l’alleanza o la subalternità, come dicevano, dell’Italia nei confronti degli USA e di conseguenza la loro estromissione dal governo e dalla maggioranza.
Le relazioni diplomatiche non erano ancora state ripristinate e De Gasperi venne invitato dall’editore del quotidiano Time per un convegno internazionale, pretesto per incontrare il presidente Harry Truman e altri esponenti di quella amministrazione, che si fece carico, comunque, di finanziare il viaggio.
Il presidente del Consiglio non disponeva di un aereo e neppure di un cappotto per ripararsi dal freddo americano di quel mese. Dovettero prestarglielo, il cappotto, e la figlia, che lo accompagnava, si procurò i pantaloni per poter prendere parte agli incontri previsti.
Accolto con comprensibile, iniziale diffidenza, egli riuscì a far valere competenza, rigore morale, chiarezza delle idee. Rappresentava un Paese vinto, distrutto e tuttavia la solidità, la dignità austera di quell’uomo colpirono gli americani e i loro rappresentanti, che al Congresso, alla presenza di Truman, in piedi lo applaudirono. Lo ascoltarono con minor gelo ma con lo stesso rispetto che gli era stato tributato al Congresso della pace di Parigi nell’anno precedente.
De Gasperi ricordò in quella circostanza che la libertà di commercio non nega la libertà del lavoro, la libertà delle comunicazioni economiche non è contro la libertà di pensiero, delle idee e del confronto. “Una libertà”, disse, “è legata all’altra”.
Nella sua visita, Meloni potrebbe utilizzare concetti analoghi per scuotere l’uomo che sta calpestando fondamentali principi di libertà di pensiero e di idee nel suo Paese, sta sconvolgendo in modo apparentemente irrazionale gli equilibri mondiali e nega perfino la libertà di commercio, imponendo dazi che hanno già provocato al nostro Paese il costo del dimezzamento delle previsioni di crescita.
Potrebbe ricordargli ciò che disse Truman in quella circostanza, “Gli Usa debbono assistere i popoli liberi a forgiare a modo loro il proprio destino”.
Con quell’incontro De Gasperi ottenne un prestito di cinquanta milioni di dollari a rimborso della collaborazione italiana alla fase finale della guerra, uno di cento milioni per l’acquisto di navi da trasporto, il trattato commerciale tra i due Paesi e la deviazione della rotta di due navi cariche di frumento verso i porti di Genova e di Napoli.
A distanza di pochi mesi George Marshall annunciava il suo piano di aiuti all’Europa per ricostruire le industrie e le infrastrutture distrutte, insieme agli edifici, dalla guerra.
Quel viaggio segnò un discrimine per la nostra politica.
Si crearono allora i presupposti per lo sviluppo economico e per la crescita sociale e civile, si affermò la democrazia dopo vent’anni di dittatura fascista e il Paese ottenne l’ammissione, primo tra i vinti, nelle istituzioni internazionali, all’ONU in particolare, di cui fece parte solo nel 1955, dopo aver superato il divieto opposto dall’Unione sovietica.
Iniziò così il percorso verso l’Unione europea con gli ottanta lunghi anni di pace, oggi pesantemente a rischio. L’Italia venne integrata nel cosiddetto “Occidente”, in contrasto duro e per fortuna pacifico con il blocco orientale che si costituiva attorno a Mosca.
A Roma, alla vigilia delle elezioni del 1948, vinte dalla Democrazia cristiana, entrò in crisi la maggioranza di governo e lo scontro con il Partito comunista, a quel tempo solidamente stalinista, divenne acceso, difficile ma comunque contenuto dalle regole della democrazia.
Fu inevitabile cedere agli Stati Uniti d’America, ormai prima potenza del mondo, una parte della sovranità nazionale. Una parte. I Paesi europei, al di là di quella che già iniziava ad essere la cortina di ferro, furono costretti invece a cederla per intero.
Torno al viaggio di oggi: Meloni in quel lontano precedente potrebbe trovare ulteriori elementi per confrontarsi con la dignità e il rigore di chi rappresenta un continente e un importante Paese. Le risulterà difficile ricondurre Trump alle buone maniere. Potrebbe semmai fargli notare che dopo il 1947 gli Stati Uniti d’America hanno esercitato la loro leadership nel mondo per la forza militare ma soprattutto per ciò che hanno saputo esprimere nel campo della musica, della letteratura, del cinema, della ricerca scientifica, dello stile di vita.
Dovrebbe ricordargli che per tanti anni gli USA sono rimasti il punto di riferimento delle democrazie del mondo in alleanza con l’Europa dalla quale, insieme a vantaggi politici ed economici, hanno ricevuto un patrimonio inestimabile di storia, esperienza, cultura e valori. Dal lavoro di milioni di donne e di uomini provenienti da questo continente, a cominciare dai nonni dello stesso Trump, avevano già avuto il contributo per diventare quello che sono. Accogliendo scienziati e ricercatori da tutto il mondo hanno reso più forte il loro primato tecnologico.
Sarebbe utile dire a Trump che la pace non si ottiene con la cessione di metà dell’Ucraina a Putin e di Gaza a Netanyahu, i responsabili dei massacri che ci sconvolgono ogni giorno di più. In tutte le guerre, del resto, se non ci si schiera per le vittime, inevitabilmente si rimane schierati per i carnefici.
C’è da sperare che la nostra presidente del Consiglio torni con risultati apprezzabili.
Si presenti comunque alla Casa Bianca in nome dell’Italia e dell’intera Europa, che vogliono restare alleate degli Stati Uniti d’America, con pari dignità, per proseguire insieme lungo la strada dello sviluppo e della pace.